Un dotto convegno di linguisti e dialettologi

Che Napoli sia diventata il ‘palcoscenico’ per un convegno con la partecipazione di una decina di autorevoli docenti universitari, venuti da tutta l’Italia per confrontarsi sul tema della salvaguardia dei patrimoni linguistici regionali nelle diverse sfaccettature locali, è senza dubbio cosa buona e giusta. E in effetti è stato proprio un palcoscenico, quello dello storico Teatro Nuovo di Montecalvario, ad ospitare la due-giorni promossa dal Comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano, operante dal 2020 in seno al Consiglio Regionale della Campania [i]. Su quella ribalta si sono affrontate questioni importanti, prima con qualificate relazioni accademiche e poi con un panel allargato ad un’esponente di quel Consiglio Regionale e ad un rappresentante degli enti locali. Era ora, d’altronde, che sulla tutela e valorizzazione delle espressioni linguistiche dei vari territori si accendessero i riflettori dell’opinione pubblica e dei media, facendo uscire questo dibattito dall’ambito esclusivamente universitario.
Il problema, semmai, è che i faretti del Teatro Nuovo – proseguo nella metafora – si sono accesi ancora una volta solo sugli studiosi, lasciando al buio (e non solo metaforicamente) il pubblico cui questi si rivolgevano. Un pubblico, in gran parte giovanile, che ha seguito in religioso silenzio gli interventi, non si sa quanto coinvolto dai sottili distinguo circa la bontà o meno di iniziative che, pur riguardanti coloro che ancora parlano le lingue locali e talvolta si arrischiano a scriverle, non li vedono affatto protagonisti del processo.
Eppure, oltre ad aprire un reale dialogo coi potenziali fruitori dei progetti di tutela e rivitalizzazione delle espressioni linguistiche locali, sarebbe stata l’occasione più opportuna per avviare un reale confronto con quelli che, volontaristicamente ed investendoci tempo e risorse personali, da più di 20 anni svolgono a Napoli corsi formativi, fanno ricerche, pubblicano contributi, promuovono iniziative culturali e si battono per ridare al Napolitano – come ad altre espressioni dialettali della Campania – la dignità di oggetto di studio e d’insegnamento.
Purtroppo tutto ciò non è accaduto e, ancora una volta, il mondo accademico ha dato l’impressione di voler ribadire il proprio ruolo, preoccupandosi di erigere autorevoli steccati nei riguardi di siffatte iniziative di base, considerate spontaneistiche ed ingenue se non deleterie, nonché di difendere la propria esclusiva relazione con le istituzioni politico-amministrative, stimolate ad investire risorse finanziarie nelle ricerche ‘scientifiche’.
Sotto i riflettori del Teatro Nuovo si sono alternati interventi autorevoli ed interessanti su cosa meriterebbe di essere ‘salvaguardato’ e sui soggetti e le modalità più idonee a tutelare il patrimonio linguistico delle regioni italiane. Da larga parte di essi – in particolare da alcuni docenti della Campania – è però apparsa in modo palese la diffidenza nei confronti dei ‘profani’ e del dilettantismo ingenuo negli interventi di formazione linguistica svolti in ambito extra-accademico, ed ancor di più verso una loro possibile, ma a quanto pare deprecabile, deriva socio-politica ‘identitaria’.
Il ruolo della linguistica, è stato ribadito più volte, sarebbe infatti quello di studiare oggettivamente i fenomeni, col necessario distacco dell’osservatore non partecipante, privilegiando un metodo descrittivo più che un approccio normativo. La lingua, si è detto, è qualcosa di vivo ed in evoluzione e i processi di cambiamento non sono arginabili. Il che è vero, se ci si riferisce ai mutamenti linguistici fisiologici nel tempo e nello spazio, ma suona quasi un pretesto laddove la naturale evoluzione di alcune lingue locali è stata condizionata dalle spinte di un centralismo autoritario e classista e da atteggiamenti conseguentemente repressivi o anche di autocensura. Decenni di studi storici e sociolinguistici rischiano così di essere sopravanzati da un’impostazione che manifesta tuttora dubbi sull’equazione tra la subalternità socio-economica e quella culturale, soprattutto nel caso del Mezzogiorno d’Italia, cercando di esorcizzare ogni forma di conflittualità tra lingua nazionale ed espressioni linguistiche identitarie territoriali, in nome di una sospetta ‘pax linguistica’, che contraddice l’affermazione dell’assenza di un vero conflitto.
Da qui il martellante ritornello sull’inesistenza di qualsivoglia connotazione spregiativa nell’utilizzo del termine ‘dialetto’, peraltro in contraddizione con gli interventi di alcuni studiosi che di tale ‘dialettofobia’ hanno viceversa portato attestazioni anche recenti. Da qui anche la pretesa di stabilire ‘ex cathedra’ chi sarebbe qualificato ad insegnare cosa e, soprattutto, dove quando e perché. Alle risposte offerte da questa sorta di 5W dell’insegnamento dei dialetti nelle scuole, infatti, sono stati dedicati vari interventi del Convegno, esprimendo rispettabili ed autorevoli pareri, ma senza aver aperto preventivamente un confronto con quei soggetti che di tale controversa materia si occupano comunque già da molti anni.
Se sia opportuna o no una simbolica ‘ora di dialetto’ nelle realtà scolastiche, oppure se ci si debba occupare delle espressioni locali solo sul piano della condivisione delle tradizioni popolari (e quindi su un piano più folkloristico che di studio e apprendimento), sono questioni legittime. Meno legittimo mi sembra invece l’atteggiamento un po’ supponente di chi mostra di aver già deciso ciò che va bene o va scartato, indirizzando unilateralmente l’operato dei comitati cui le amministrazioni regionali si sono affidate.
Non a caso, già nella conferenza stampa di presentazione del Convegno – tenuta nella sede regionale – si era affermato che il suo compito era quello di “…definire gli ambiti linguistici, geografici e culturali del patrimonio linguistico napoletano, individuare modalità per la valorizzazione di un patrimonio linguistico e delineare le possibili iniziative per veicolare conoscenze adeguate sulla storia linguistica italiana e sulla variegata articolazione dell’area regionale campana” [ii]. Una terminologia che già nei verbi usati (definire, individuare, delineare) tradiva la volontà di frapporre precisi paletti, delimitando preventivamente il terreno di tale sperimentazione.
Sul sito della Federico II si legge che: “…il Convegno proporrà tra l’altro una riflessione su come nella scuola italiana del XXI secolo possa delinearsi – senza antagonismi con la lingua italiana – uno spazio per il dialetto, con una consapevole attenzione verso le manifestazioni culturali e artistiche legate ai patrimoni linguistici locali” [iii]. Ma, più che una riflessione sul ‘come’ salvaguardare i patrimoni linguistici delle nostre regioni, dal convegno sembra essere scaturita una vera e propria ricetta, anticipando le ‘linee guida’ che il Comitato sembrerebbe voler dare non solo al suo operato, ma anche alle realtà informali che agiscono sul campo. Ad esempio privilegiando palesemente l’attenzione verso le manifestazioni artistico-culturali più ‘popolari’ ma mostrando diffidenza nei confronti dello studio scolastico delle caratteristiche lessico-grammaticali e fonetico-ortografiche dei vari dialetti, attività considerata forse foriera di spiacevoli ‘antagonismi’ con la lingua italiana… Oppure insistendo nell’affermazione che le legislazioni regionali in materia tendono a privilegiare le espressioni linguistiche delle principali metropoli (si tratti di Venezia come di Napoli, di Roma come di Palermo), ipotizzando quindi sedicenti lingue regionali o addirittura elaborando linguaggi artificialmente standardizzati. Tendenze che, pur presenti in alcune normative in vigore, non nascono tanto dagli orientamenti di chi opera sul terreno, quanto dai condizionamenti politici degli organi legislativi.
Il caso della Campania: una legge mutilata

È successo ovviamente anche nel caso della Legge regionale della Campania n. 14/2019 (vedi testo), frutto d’un difficile compromesso tra la proposta avanzata dai Verdi (che io stesso ero stato incaricato di articolare) e quella presentata dalla Destra. La risposta a molte delle obiezioni e perplessità espresse nel corso del Convegno sta proprio in questa ambiguità di fondo, che ha di fatto tradito alcune istanze presenti nella prima proposta. Già nel titolo, ad esempio, si notano le differenze. Quella partorita 3 anni e mezzo fa dal Consiglio Regionale della Campania (il cui organismo attuatore è proprio il Comitato Scientifico organizzatore del Convegno) annuncia sbrigativamente “Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano”, laddove il progetto originario parlava più latamente di “Norme per lo studio, la tutela e la valorizzazione della Lingua Napoletana, dei Dialetti e delle Tradizioni Popolari della Campania”.
Le differenze proseguono all’articolo 1, laddove tra le finalità nel testo vigente leggiamo che: “2. La Regione Campania valorizza il suo patrimonio culturale, promuove e favorisce la conservazione e l’uso sociale dei beni culturali linguistici, etnomusicali e delle tradizioni popolari, con particolare riguardo alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano”. Da questo articolo, pur citando la Dichiarazione Universale dell’UNESCO sulla diversità linguistica, è sparito invece l’iniziale riferimento alla Carta Europea delle Lingue Regionali, approvata nel 1992 dal Consiglio d’Europa, che è molto più chiara sulla finalità di facilitarne l’uso orale e scritto “agevolandone lo studio e l’insegnamento”. Conseguentemente, è stato cassato anche l’art. 3 del progetto di legge originario, dove si prevedeva esplicitamente che “la Regione Campania tutela e valorizza il patrimonio storico-culturale e letterario connesso alla lingua napoletana anche mediante il suo insegnamento – e la conoscenza degli altri idiomi della Campania – nelle scuole di ogni ordine e grado”. Nella legge in vigore, conseguentemente, è rimasto solo un generico riferimento ad “iniziative rivolte alla popolazione scolastica”.
Le premesse della proposta di legge, pertanto, erano molto più articolate di quanto emerge dal testo poi approvato, riferendosi al principio – democratico ed ecolinguistico – del rispetto della diversità linguistica in tutte le sue manifestazioni, senza affatto ipotizzare la preminenza di un idioma su un altro. Appare allora un po’ pretestuosa l’osservazione di chi – in un articolo sul quotidiano Il Mattino – ha scritto : “…si pensa che tutti i dialetti siano, individualmente e nel loro insieme, testimoni di storia e di una tradizione linguistica ricca proprio perché variegata? Oppure si pensa che la salvaguardia debba riguardare solo alcuni dialetti proclamati unici o migliori?” [iv] Domanda retorica che prelude alla successiva obiezione: “Si parla spesso di introdurre i dialetti nella scuola. In questo campo più che mai sono indispensabili obiettivi chiari: qualcuno crede che la scuola, con didattica normativa, dovrebbe impartire agli scolari la capacità di usare fluentemente il dialetto? Oppure si vuole insegnare solo la grafia di un dialetto a scolari che in futuro vorranno scrivere poesie, canzoni o altre opere? In entrambe le prospettive (tra loro diverse), bisognerebbe precisare quale dialetto scegliere tra i tanti di una regione…”. [v]
Il punto centrale della contestazione portata avanti da alcuni esponenti del mondo accademico (e sintetizzata in quell’articolo) riguarda le finalità stesse di un eventuale insegnamento dei dialetti nelle scuole, manifestando un atteggiamento sospettoso verso ipotetici obiettivi di contrapposizione di essi alla lingua comune e ufficiale.
“Molti, se si considera ciò che si legge in giro e in rete, credono che tutti i dialetti abbiano subito torti gravissimi e volontari a causa della diffusione dell’italiano, tanto che a volte l’idea di salvaguardia sembra abbinata a un senso di rivalsa […] Anche nella didattica, con insegnanti che abbiano padronanza della materia, si potrà in ogni luogo prevedere, in rapporto all’età dei discenti, un’attenzione verso il dialetto […] ma senza esaltazioni e senza l’idea che qualcuno abbia messo in atto oppressioni o deprivazioni a danno di altri”. [vi]
Ecco il punto: esorcizzare ogni potenziale intenzione di ‘rivalsa’ sembrerebbe più importante che promuovere lingue locali che hanno subito viceversa un’innegabile riduzione a parlate ‘volgari’, da confinare semmai in ambito familiare perché inadatte ad esprimere contenuti ‘alti’. La decisa negazione di ogni forma di “oppressioni o deprivazioni” cozza inoltre contro decenni di studi sociolinguistici che hanno messo in evidenza quanto la marginalità socio-economica della gente del Sud comportasse anche la deprivazione delle loro specifiche espressioni linguistiche. Non si tratta di perseguire ‘rivalse’ o di una sorta di revanscismo culturale o politico, ma della legittima affermazione della pari dignità di tutte le espressioni linguistiche, evitando che quelle più marginalizzate vengano ridotte a manifestazioni folkloristiche minoritarie su cui fare solo ricerche. La rivitalizzazione delle lingue locali è quindi manifestazione d’identità culturali particolari che non si contrappongono necessariamente a quella nazionale, ma restituiscono dignità e diritti a chi per troppo tempo ha subito la marginalizzazione di un processo unitario di stampo coloniale. Come ho già scritto in proposito: “Tutelare il diritto delle minoranze etnolinguistiche si è rivelato più agevole che salvaguardare e garantire un futuro a lingue considerate ‘minoritaie’ o ‘regionali’, che non rischiano l’estinzione bensì l’accantonamento, lo snaturamento e la corruzione sul piano lessicale, grammaticale ed ortografico” (E.Ferraro, Grammatica ecopacifista, Pisa, Centro Gandhi Edizioni, 2022, p. 92).
Il paradosso, semmai, è che la rivendicazione di un’autonomia linguistica vera e propria – sul modello delle battaglie per la rivitalizzazione del catalano, del provenzale o dello scozzese – non proviene affatto dalle regioni meridionali che più hanno sofferto il peso della subalternità socio-economica e culturale, bensì da quelle ricche e forti del Nord, come la Lombardia e il Veneto. A noi del Sud basterebbe che le lingue locali delle nostre genti non fossero più mortificate, consentendo di recuperare e valorizzare espressioni idiomatiche e culturali del tutto originali. Uno dei modi per marginalizzare i cosiddetti dialetti è stata la loro riduzione a strumenti utili solo per la comunicazione familiare, o anche in ambiti esterni ma limitati come il teatro popolare, la poesia vernacolare o le canzoni. L’insistenza – ancora una volta – sull’opportunità di confinarne lo studio esclusivamente nel recinto “delle tradizioni e (del)la storia (nomi di luogo, usi gastronomici, etimologie, letteratura, altri usi artistici” [vii] mi sembra quindi che confermi il diffuso pregiudizio sulla loro inadeguatezza in altri ambiti comunicativi (ad es. giornali ed altri media, ma anche produzioni in prosa o ricerche di altro genere).

L’autoreferenzialità di un mondo accademico che dialoga con se stesso, ignorando il confronto con chi, sul terreno concreto, da decenni si sta battendo per ridare dignità agli idiomi locali, non è un segnale positivo di apertura al dialogo. Nel caso della Campania, la banalizzazione della proposta di legge iniziale per renderla utile solo ad elargire finanziamenti a manifestazioni folkloristiche ed a ricerche accademiche, è stato un altro segnale negativo. Fatto sta che chi si spende ogni giorno per difendere e promuovere il Napolitano ed altre espressioni linguistiche campane continuerà a farlo sempre e comunque. Malgrado che da questo convegno sia emersa la preoccupazione, più che di salvaguardare queste lingue, di porre la loro promozione sotto l’autorevole ‘tutela’ degli esperti…
Note
[i] https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/convegno-salvaguardare-un-patrimonio-linguistico/31069 . Su finalità, composizione e attività del Comit. cfr. https://cr.campania.it/comvalnap/
[ii] https://www.lapilli.eu/3.0/agenda/4069-salvaguardare-e-valorizzare-il-patrimonio-linguistico-napoletano-idee-fatti-e-prospettive
[iii] https://www.unina.it/-/34934236-salvaguardare-un-patrimonio-linguistico
[iv] Nicola De Blasi, Dialetti, ecco le iniziative per il patrimonio linguistico napoletano: difendiamo i dialetti (anche) dalle fake news, IL MATTINO, 13/12/2022
[v] Ibidem
[vi] Ibidem
[vii] Ibidem








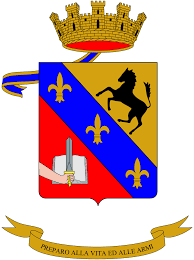









 Ci siamo scordati la pace?
Ci siamo scordati la pace?  E’ abbastanza evidente che – fatta eccezione per le ‘competenze sociali e civiche’ , quelle che chiamiamo ‘di cittadinanza’ – nell’elenco delle priorità formative manca un riferimento esplicito a quelle che abbiano a che fare con la crescita della consapevolezza della natura dei conflitti e con la promozione della pace come alternativa concreta alla violenza personale e strutturale che affligge la nostra realtà. Leggendo con attenzione i documenti del Ministero dell’Istruzione italiano (MIUR), ed in particolare le famose ‘Indicazioni’ del 2012, apprendiamo certamente che la formazione scolastica dovrebbe sviluppare negli studenti adeguate competenze civico-sociali, ma non si va oltre la genericità di tali affermazioni.
E’ abbastanza evidente che – fatta eccezione per le ‘competenze sociali e civiche’ , quelle che chiamiamo ‘di cittadinanza’ – nell’elenco delle priorità formative manca un riferimento esplicito a quelle che abbiano a che fare con la crescita della consapevolezza della natura dei conflitti e con la promozione della pace come alternativa concreta alla violenza personale e strutturale che affligge la nostra realtà. Leggendo con attenzione i documenti del Ministero dell’Istruzione italiano (MIUR), ed in particolare le famose ‘Indicazioni’ del 2012, apprendiamo certamente che la formazione scolastica dovrebbe sviluppare negli studenti adeguate competenze civico-sociali, ma non si va oltre la genericità di tali affermazioni. Nella ‘scuola Pon-Pon’ , tutta presa dalla digitalizzazione dell’insegnamento
Nella ‘scuola Pon-Pon’ , tutta presa dalla digitalizzazione dell’insegnamento  Concludo riportando quanto scrivevo dieci anni fa, tuttora valido, a proposito della metodologia più idonea al perseguimento di un’educazione alla pace che non resti sconnessa dal contesto formativo, ma caratterizzi il nostro lavoro di docenti e lasci una traccia effettiva nei nostri studenti.
Concludo riportando quanto scrivevo dieci anni fa, tuttora valido, a proposito della metodologia più idonea al perseguimento di un’educazione alla pace che non resti sconnessa dal contesto formativo, ma caratterizzi il nostro lavoro di docenti e lasci una traccia effettiva nei nostri studenti. Alla fine il momento è arrivato. Questo 9 marzo ho compiuto 66 anni, approssimandomi al giro di boa costituito del termine della mia carriera lavorativa. Permettetemi allora di divagare un po’ a partire da questo 66 che, oltre ad evocare la citazione di Kerouac, è un numero palindromo particolarmente significativo e simbolico, che coi due 6 che occhieggiano appaiati mi trasmette un senso di stabilità e al tempo stesso di dinamismo. In effetti si tratta di una divagazione piuttosto strana ed insolita per uno come me, che ha sempre avuto problemi con la matematica e non è neanche appassionato di ‘numerologia’ e dottrine cabalistiche. Eppure mi sembra sia innegabile che esista una certa ‘magia’ dei e nei numeri, per cui essi…contano davvero. Preso dalla curiosità, quindi, mi sono un po’ documentato in materia, attingendo da internet alcuni spunti.
Alla fine il momento è arrivato. Questo 9 marzo ho compiuto 66 anni, approssimandomi al giro di boa costituito del termine della mia carriera lavorativa. Permettetemi allora di divagare un po’ a partire da questo 66 che, oltre ad evocare la citazione di Kerouac, è un numero palindromo particolarmente significativo e simbolico, che coi due 6 che occhieggiano appaiati mi trasmette un senso di stabilità e al tempo stesso di dinamismo. In effetti si tratta di una divagazione piuttosto strana ed insolita per uno come me, che ha sempre avuto problemi con la matematica e non è neanche appassionato di ‘numerologia’ e dottrine cabalistiche. Eppure mi sembra sia innegabile che esista una certa ‘magia’ dei e nei numeri, per cui essi…contano davvero. Preso dalla curiosità, quindi, mi sono un po’ documentato in materia, attingendo da internet alcuni spunti. Dividendo 6 per se stesso si ottiene naturalmente 1, numero che mi fa tornare indietro al mio primo anno di vita, nel 1953, quando una foto dell’epoca mi ritrae con dei riccetti biondi in testa ed un sorriso beato sulla faccia. Allora la mia famiglia abitava a via Luca Giordano, in un palazzotto adiacente la storica villa ottocentesca che ricorda quella con parco, di quattro secoli precedente, dove dimorava l’umanista Gioviano Pontano, che si affacciava sull’antico borgo di Antignano. Di quel remoto periodo naturalmente non ricordo quasi nulla. Dei miei primi anni mi restano soltanto vaghe memorie dei suoni e degli odori che promanavano dal vivace e rumoroso mercatino ortofrutticolo sottostante, cuore popolare di un quartiere borghese sorto in epoca umbertina dove una volta dominavano le coltivazioni di broccoli e dove cantavano, strofinando i panni, le ‘lavandaie’ del Vomero immortalate in una delle più antiche testimonianze canore napolitane. Mi tornano alla mente solo le pittoresche ‘voci’ dei venditori di allora, l’odore penetrante di una vicina torrefazione di caffè ed il profumo delle broches appena sfornate da una vicina pasticceria. Era l’anno in cui Totò portava sugli schermi il suo spassoso ‘Un Turco napoletano’
Dividendo 6 per se stesso si ottiene naturalmente 1, numero che mi fa tornare indietro al mio primo anno di vita, nel 1953, quando una foto dell’epoca mi ritrae con dei riccetti biondi in testa ed un sorriso beato sulla faccia. Allora la mia famiglia abitava a via Luca Giordano, in un palazzotto adiacente la storica villa ottocentesca che ricorda quella con parco, di quattro secoli precedente, dove dimorava l’umanista Gioviano Pontano, che si affacciava sull’antico borgo di Antignano. Di quel remoto periodo naturalmente non ricordo quasi nulla. Dei miei primi anni mi restano soltanto vaghe memorie dei suoni e degli odori che promanavano dal vivace e rumoroso mercatino ortofrutticolo sottostante, cuore popolare di un quartiere borghese sorto in epoca umbertina dove una volta dominavano le coltivazioni di broccoli e dove cantavano, strofinando i panni, le ‘lavandaie’ del Vomero immortalate in una delle più antiche testimonianze canore napolitane. Mi tornano alla mente solo le pittoresche ‘voci’ dei venditori di allora, l’odore penetrante di una vicina torrefazione di caffè ed il profumo delle broches appena sfornate da una vicina pasticceria. Era l’anno in cui Totò portava sugli schermi il suo spassoso ‘Un Turco napoletano’  La radice quadrata di 66 è 8,124…Semplificando a 8, questo numero mi fa risalire al mio ottavo anno di età, nel 1960. Era il periodo della scuola elementare e, più precisamente, del penultimo anno in cui ho frequentato l’austero edificio della ‘Luigi Vanvitelli’, con le sue aule alte e solenni ed i banchi neri di legno, per poi trasferirmi alla luminosa ed allora modernissima scuola ‘ Quarati’, più vicina alla mia nuova abitazione di via Francesco Cilea, dove la mia famiglia si trasferì nel ‘62. Di quel biennio delle elementari ovviamente ricordo assai poco, a parte il primo impegno per sostenere l’esame d’idoneità, allora previsto per passare alla terza classe. L’Ermete di allora, più alto della media e rigorosamente rivestito del classico grembiule nero con fiocco colorato a seconda della classe frequentata, era sicuramente molto studioso e piuttosto timido, ma amichevole con tutti. Uno degli ultimi ricordi che ho della ‘Vanvitelli’ è un concerto di fine d’anno durante il quale, non sapendo quale strumento farmi suonare, mi consegnarono un bel triangolo ed una bacchetta con cui percuoterlo, possibilmente a tempo con la musica…Purtroppo quella fu la prima ed ultima mia esibizione come suonatore di strumento, il che è piuttosto paradossale se si considera che da anni insegno lettere proprio in una sezione musicale…
La radice quadrata di 66 è 8,124…Semplificando a 8, questo numero mi fa risalire al mio ottavo anno di età, nel 1960. Era il periodo della scuola elementare e, più precisamente, del penultimo anno in cui ho frequentato l’austero edificio della ‘Luigi Vanvitelli’, con le sue aule alte e solenni ed i banchi neri di legno, per poi trasferirmi alla luminosa ed allora modernissima scuola ‘ Quarati’, più vicina alla mia nuova abitazione di via Francesco Cilea, dove la mia famiglia si trasferì nel ‘62. Di quel biennio delle elementari ovviamente ricordo assai poco, a parte il primo impegno per sostenere l’esame d’idoneità, allora previsto per passare alla terza classe. L’Ermete di allora, più alto della media e rigorosamente rivestito del classico grembiule nero con fiocco colorato a seconda della classe frequentata, era sicuramente molto studioso e piuttosto timido, ma amichevole con tutti. Uno degli ultimi ricordi che ho della ‘Vanvitelli’ è un concerto di fine d’anno durante il quale, non sapendo quale strumento farmi suonare, mi consegnarono un bel triangolo ed una bacchetta con cui percuoterlo, possibilmente a tempo con la musica…Purtroppo quella fu la prima ed ultima mia esibizione come suonatore di strumento, il che è piuttosto paradossale se si considera che da anni insegno lettere proprio in una sezione musicale… concludere il biennio ginnasiale al prestigioso Liceo Classico ‘Jacopo Sannazaro’, esibendo una capigliatura più folta ed un’ombra di baffetti, ma restando sempre piuttosto schivo. Sono stati gli anni dell’approccio con il latino e greco, dominati per un terzo delle ore di scuola dalla figura della mia esigente docente di lettere, che però riuscì a farmi amare i ‘Promessi sposi’. Lo stesso successo non arrise però all’ironica e spicciativa professoressa di matematica. Ricordo invece con una certa simpatia l’anziano e bizzarro prof di francese, con le sue inesorabili ‘tre frasi alla lavagna’ e con la pretesa di farci sciroppare intere tragedie di Corneille e Racine. Era quello l’anno della tragica alluvione di Firenze, la cui cronaca fu uno dei primi esempi di diretta televisiva che colpì centinaia di migliaia d’Italiani, spingendo molti giovani a diventare volontari a fianco della traballante protezione civile del tempo. Era anche un anno culminante della rivoluzione culturale in Cina e, venendo al cinema, quello del celebre western all’italiana di Sergio Leon e ‘Il Buono, il Brutto e il Cattivo’ , ma anche del raffinato “Uccellacci e uccellini” di Pasolini.
concludere il biennio ginnasiale al prestigioso Liceo Classico ‘Jacopo Sannazaro’, esibendo una capigliatura più folta ed un’ombra di baffetti, ma restando sempre piuttosto schivo. Sono stati gli anni dell’approccio con il latino e greco, dominati per un terzo delle ore di scuola dalla figura della mia esigente docente di lettere, che però riuscì a farmi amare i ‘Promessi sposi’. Lo stesso successo non arrise però all’ironica e spicciativa professoressa di matematica. Ricordo invece con una certa simpatia l’anziano e bizzarro prof di francese, con le sue inesorabili ‘tre frasi alla lavagna’ e con la pretesa di farci sciroppare intere tragedie di Corneille e Racine. Era quello l’anno della tragica alluvione di Firenze, la cui cronaca fu uno dei primi esempi di diretta televisiva che colpì centinaia di migliaia d’Italiani, spingendo molti giovani a diventare volontari a fianco della traballante protezione civile del tempo. Era anche un anno culminante della rivoluzione culturale in Cina e, venendo al cinema, quello del celebre western all’italiana di Sergio Leon e ‘Il Buono, il Brutto e il Cattivo’ , ma anche del raffinato “Uccellacci e uccellini” di Pasolini.  In quegli stessi anni, infatti, sono stato poi referente d’istituto per l’educazione alla legalità e successivamente ‘funzione-obiettivo’ per l’area del c.d. ‘disagio’, cercando di mettere a frutto gli anni di lavoro e ricerca sociale anche nella mia attività di docente. Nel 1988 stavo approssimandomi anche al matrimonio con Anna, conosciuta un anno e mezzo prima in occasione della formazione della prima Lista Verde a Napoli, che mi permise di diventare il primo consigliere circoscrizionale ambientalista al Vomero e d’iniziare un nuovo percorso, che non è ancora finito.
In quegli stessi anni, infatti, sono stato poi referente d’istituto per l’educazione alla legalità e successivamente ‘funzione-obiettivo’ per l’area del c.d. ‘disagio’, cercando di mettere a frutto gli anni di lavoro e ricerca sociale anche nella mia attività di docente. Nel 1988 stavo approssimandomi anche al matrimonio con Anna, conosciuta un anno e mezzo prima in occasione della formazione della prima Lista Verde a Napoli, che mi permise di diventare il primo consigliere circoscrizionale ambientalista al Vomero e d’iniziare un nuovo percorso, che non è ancora finito.
 Il Mahatma Gandhi – della cui morte si celebra il 70° anniversario – ci invitava ad “essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo”. E’ una delle sue frasi più famose e citate, ma forse oggi dovremmo interrogarci preliminarmente se noi adulti siamo ancora capaci di perseguire una visione del mondo che ci porti a quel cambiamento cui dovremmo improntare i nostri comportamenti. Non si tratta, secondo me, soltanto dell’abituale incoerenza tra fini e mezzi – che ha sempre finito col giustificare la violenza – ma di una più sostanziale perdita di una prospettiva che ci motivi davvero al cambiamento. Sappiamo bene che ogni forma di aggressività nasce in qualche modo dalla diffidenza, dalla paura, dalla difesa del sé, dal rifiuto dell’idea stessa che gli altri c’impongano la loro volontà. In assenza di certezze sulla solidità dei legami che dovrebbero unirci, questa paura dell’altro è quindi diventata ancora maggiore, alimentata da diffidenze , egoismi e meccanismi di autodifesa, capaci di trasformarsi anche in strumenti di offesa preventiva.
Il Mahatma Gandhi – della cui morte si celebra il 70° anniversario – ci invitava ad “essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo”. E’ una delle sue frasi più famose e citate, ma forse oggi dovremmo interrogarci preliminarmente se noi adulti siamo ancora capaci di perseguire una visione del mondo che ci porti a quel cambiamento cui dovremmo improntare i nostri comportamenti. Non si tratta, secondo me, soltanto dell’abituale incoerenza tra fini e mezzi – che ha sempre finito col giustificare la violenza – ma di una più sostanziale perdita di una prospettiva che ci motivi davvero al cambiamento. Sappiamo bene che ogni forma di aggressività nasce in qualche modo dalla diffidenza, dalla paura, dalla difesa del sé, dal rifiuto dell’idea stessa che gli altri c’impongano la loro volontà. In assenza di certezze sulla solidità dei legami che dovrebbero unirci, questa paura dell’altro è quindi diventata ancora maggiore, alimentata da diffidenze , egoismi e meccanismi di autodifesa, capaci di trasformarsi anche in strumenti di offesa preventiva. Ovviamente quando faccio questa affermazione mi riferisco alla gentilezza autentica, che viene dal cuore e dalla mente, non alle generiche ‘buone maniere’, che ne costituiscono un’etichetta esteriore ed un po’ ipocrita, sebbene parzialmente da riscoprire in tempi di arroganza e volgarità.
Ovviamente quando faccio questa affermazione mi riferisco alla gentilezza autentica, che viene dal cuore e dalla mente, non alle generiche ‘buone maniere’, che ne costituiscono un’etichetta esteriore ed un po’ ipocrita, sebbene parzialmente da riscoprire in tempi di arroganza e volgarità.
 Si tratta di un addestramento quotidiano, attraverso il quale i ragazzi possano comprendere – praticandola – che la gentilezza non ci sminuisce, non ci rende più fragili ed esposti, ma piuttosto ci fortifica interiormente, ci apre all’altro e ne smonta l’aggressività. La mitezza evangelica
Si tratta di un addestramento quotidiano, attraverso il quale i ragazzi possano comprendere – praticandola – che la gentilezza non ci sminuisce, non ci rende più fragili ed esposti, ma piuttosto ci fortifica interiormente, ci apre all’altro e ne smonta l’aggressività. La mitezza evangelica  Costruiamo insieme, dunque, una cultura della gentilezza, utilizzando gli insegnamenti della saggezza antica ed i precetti morali della religione, ma anche quello che c’insegna la psicologia. Ce n’è tanto bisogno e non possiamo limitarci ad aspettare che siano gli altri a prendere l’iniziativa. Ecco perché, gandhianamente, dobbiamo sforzarci di diventare il cambiamento che vorremmo vedere nel mondo. Facciamolo però senza sentirci superiori agli altri, anzi perdonandoci la nostra stessa debolezza, praticando in tal modo la gentilezza prima verso noi stessi.
Costruiamo insieme, dunque, una cultura della gentilezza, utilizzando gli insegnamenti della saggezza antica ed i precetti morali della religione, ma anche quello che c’insegna la psicologia. Ce n’è tanto bisogno e non possiamo limitarci ad aspettare che siano gli altri a prendere l’iniziativa. Ecco perché, gandhianamente, dobbiamo sforzarci di diventare il cambiamento che vorremmo vedere nel mondo. Facciamolo però senza sentirci superiori agli altri, anzi perdonandoci la nostra stessa debolezza, praticando in tal modo la gentilezza prima verso noi stessi. E’ questo l’incipit dell’Appello per la Scuola Pubblica, che ho appena sottoscritto e che invito tutti/e a leggere con grande attenzione.
E’ questo l’incipit dell’Appello per la Scuola Pubblica, che ho appena sottoscritto e che invito tutti/e a leggere con grande attenzione.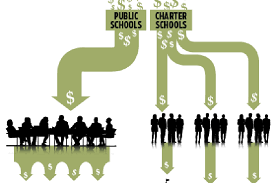 E’ solo il nostro provincialismo italiota che non ci fa cogliere i nessi fra quello che ci sta capitando e le profonde – in alcuni case antiche – radici che sono all’origine di quello che ho chiamato ‘snaturamento’ della scuola. E’ da questa sua profonda ‘modificazione genetica’, infatti, che derivano le linee di tendenza che sono sicuramente tutte dentro le ultime riforme della scuola italiana – in particolare quella renziana – ma che, in modo più strisciante e progressivo, hanno inquinato fini, mezzi e modi dell’insegnamento, riconducendoli alla logica neo-liberista delle privatizzazioni, della selezione pseudo-meritocratica, della ‘managerialità’ dei dirigenti e della deregulation in ambito normativo, per di più spacciando tutto ciò come attuazione della autonomia scolastica. Sono questi i ‘modelli produttivistici’ cui l’Appello fa risalire la ‘destrutturazione’ della nostra scuola pubblica, denunciandone la matrice ideologica ‘economicista ed efficientista’.
E’ solo il nostro provincialismo italiota che non ci fa cogliere i nessi fra quello che ci sta capitando e le profonde – in alcuni case antiche – radici che sono all’origine di quello che ho chiamato ‘snaturamento’ della scuola. E’ da questa sua profonda ‘modificazione genetica’, infatti, che derivano le linee di tendenza che sono sicuramente tutte dentro le ultime riforme della scuola italiana – in particolare quella renziana – ma che, in modo più strisciante e progressivo, hanno inquinato fini, mezzi e modi dell’insegnamento, riconducendoli alla logica neo-liberista delle privatizzazioni, della selezione pseudo-meritocratica, della ‘managerialità’ dei dirigenti e della deregulation in ambito normativo, per di più spacciando tutto ciò come attuazione della autonomia scolastica. Sono questi i ‘modelli produttivistici’ cui l’Appello fa risalire la ‘destrutturazione’ della nostra scuola pubblica, denunciandone la matrice ideologica ‘economicista ed efficientista’.  Quando l’appello elenca i sette punti ‘caldi’ da tenere presenti se si vuole salvare quel che ancora rimane della scuola pubblica, risulta evidente che il processo che la sta “destrutturando” va proprio nella direzione delle charter schools d’oltre oceano. All’enfasi esagerata sulle competenze basilari e sulle tecnologie digitali, ad esempio, il documento giustamente contrappone una riserva:
Quando l’appello elenca i sette punti ‘caldi’ da tenere presenti se si vuole salvare quel che ancora rimane della scuola pubblica, risulta evidente che il processo che la sta “destrutturando” va proprio nella direzione delle charter schools d’oltre oceano. All’enfasi esagerata sulle competenze basilari e sulle tecnologie digitali, ad esempio, il documento giustamente contrappone una riserva: Gli ultimi tre dei sette ‘peccati capitali’ della #BuonaScuola hanno a che fare col grande capitolo di ciò che gli autori dell’Appello chiamano “metrica dell’educazione e della ricerca”.
Gli ultimi tre dei sette ‘peccati capitali’ della #BuonaScuola hanno a che fare col grande capitolo di ciò che gli autori dell’Appello chiamano “metrica dell’educazione e della ricerca”. Nelle scuole italiane, da un po’ di tempo in qua, non si fa altro che discutere animatamente dello stesso argomento. Del rinnovo del contratto del personale, incredibilmente fermo da 10 anni? Degli esiti della sedicente Buona Scuola renziana, che ci ha regalato presidi-manager e docenti-staffisti? Dell’atteggiamento schizofrenico di chi, dopo aver cancellato l’ora d’insegnamento dedicata alla ‘educazione civica’ l’ha rimpiazzata dapprima con un’indistinta girandola di educazioni (alla legalità, alimentare, sanitaria, etc.) e poi con l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione all’interno di una delle due curricolari ore di storia e senza una valutazione specifica? Oppure si discute della logica ‘premiale’ bonascolista, che tratta gli insegnanti come bambini che scrivono a Babbo Natale per mendicare umilmente bonus, ricompense e mance varie? O forse si parla della aziendalizzazione spinta della scuola pubblica, pervasa da slogan efficientistico-imprenditoriali e sempre più invasa da postulanti privati a vario titolo (docenti di madre-lingua, istituti di certificazione linguistica, teatri e cinematografi, associazioni turistiche e culturali, club sportivi, providers informatici, formatori in cerca di pubblico e via discorrendo)? Assolutamente no. Il problema-principe di cui si discetta nelle nostre scuole è l’uragano abbattutosi improvvisamente e improvvidamente su docenti stanchi, spesso avviliti e demotivati, ponendoli di fronte ad un obbligo ulteriore e mortificante. Quello cioè di attuare nella realtà vera di tutti i giorni – e soprattutto degli anni 2000 – una prescrizione normativa risalente al Codice Rocco, secondo la quale i ‘minori’ loro affidati dai genitori, all’uscita dalla scuola, dovrebbero essere individualmente consegnati a questi ultimi o a loro delegati.
Nelle scuole italiane, da un po’ di tempo in qua, non si fa altro che discutere animatamente dello stesso argomento. Del rinnovo del contratto del personale, incredibilmente fermo da 10 anni? Degli esiti della sedicente Buona Scuola renziana, che ci ha regalato presidi-manager e docenti-staffisti? Dell’atteggiamento schizofrenico di chi, dopo aver cancellato l’ora d’insegnamento dedicata alla ‘educazione civica’ l’ha rimpiazzata dapprima con un’indistinta girandola di educazioni (alla legalità, alimentare, sanitaria, etc.) e poi con l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione all’interno di una delle due curricolari ore di storia e senza una valutazione specifica? Oppure si discute della logica ‘premiale’ bonascolista, che tratta gli insegnanti come bambini che scrivono a Babbo Natale per mendicare umilmente bonus, ricompense e mance varie? O forse si parla della aziendalizzazione spinta della scuola pubblica, pervasa da slogan efficientistico-imprenditoriali e sempre più invasa da postulanti privati a vario titolo (docenti di madre-lingua, istituti di certificazione linguistica, teatri e cinematografi, associazioni turistiche e culturali, club sportivi, providers informatici, formatori in cerca di pubblico e via discorrendo)? Assolutamente no. Il problema-principe di cui si discetta nelle nostre scuole è l’uragano abbattutosi improvvisamente e improvvidamente su docenti stanchi, spesso avviliti e demotivati, ponendoli di fronte ad un obbligo ulteriore e mortificante. Quello cioè di attuare nella realtà vera di tutti i giorni – e soprattutto degli anni 2000 – una prescrizione normativa risalente al Codice Rocco, secondo la quale i ‘minori’ loro affidati dai genitori, all’uscita dalla scuola, dovrebbero essere individualmente consegnati a questi ultimi o a loro delegati. “Il padre e la madre, o il
“Il padre e la madre, o il  Spesso i docenti tendono a reagire d’istinto alle…sollecitazioni provenienti dall’alto, dimostrando talvolta una limitata consapevolezza dei propri diritti e doveri. Bisogna ammettere, d’altra parte, che non passa anno che sul travagliato microcosmo scolastico non si abbatta qualche inopinata novità, che mette in discussione gli equilibri organizzativi e introduce elementi innovativi nella stessa didattica, costringendo stagionati maestri e professori ad adeguarsi alla meglio ad essi. Come osservavo qualche anno fa in un altro articolo
Spesso i docenti tendono a reagire d’istinto alle…sollecitazioni provenienti dall’alto, dimostrando talvolta una limitata consapevolezza dei propri diritti e doveri. Bisogna ammettere, d’altra parte, che non passa anno che sul travagliato microcosmo scolastico non si abbatta qualche inopinata novità, che mette in discussione gli equilibri organizzativi e introduce elementi innovativi nella stessa didattica, costringendo stagionati maestri e professori ad adeguarsi alla meglio ad essi. Come osservavo qualche anno fa in un altro articolo  Il paradosso è che, anziché preoccuparsi davvero del grave problema dei veri “minori non accompagnati”, ovvero i circa 30.000 ragazzi/e stranieri (dato 2016) che da soli hanno fortunosamente raggiunto il nostro Paese e per i quali sussiste un oggettivo diritto di accoglienza e protezione
Il paradosso è che, anziché preoccuparsi davvero del grave problema dei veri “minori non accompagnati”, ovvero i circa 30.000 ragazzi/e stranieri (dato 2016) che da soli hanno fortunosamente raggiunto il nostro Paese e per i quali sussiste un oggettivo diritto di accoglienza e protezione